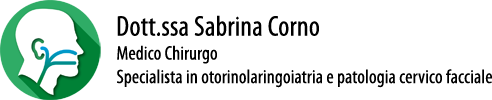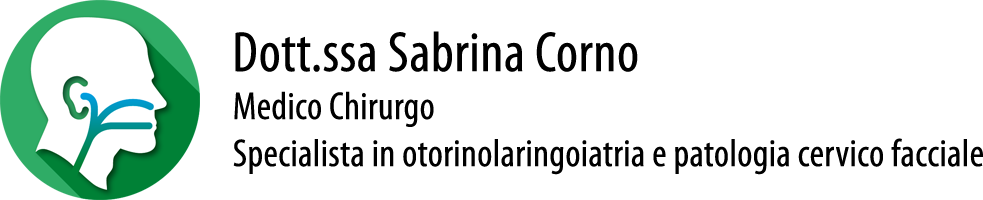La Vertigine Posizionale Parossistica Benigna
La Vertigine Posizionale Parossistica Benigna
Cosa è la Vertigine Posizionale Parossistica Benigna? La vertigine parossistica posizionale (VPP) è la sindrome vertiginosa periferica in assoluto più frequente nella pratica clinica otoneurologica ed è caratterizzata da vertigini a crisi, intense e brevi, parossistiche, della durata di secondi e scatenate da alcuni movimenti particolari del capo.
Etiologia della Vertigine Posizionale Parossistica Benigna
Per la VPP vi è una sola causa che può essere detta certa e cioè quella traumatica: solo in questi casi infatti è possibile stabilire un rapporto di causa effetto certo.
In letteratura circa il 50% delle VPP deve essere classificata come idiopatica, cioè senza causa apparente. Nei rimanenti casi si può associare l’insorgenza della VPP con altri eventi che coinvolgono il labirinto, come una neurolabirintite virale, una perdita improvvisa della funzione vestibolare monolaterale da causa vascolare, oppure interventi di chirurgia otologica, tutte condizioni che in qualche modo abbiano potuto determinare un distacco diretto di otoconi dalla macula dell’utricolo o la loro degenerazione o abbiano alterato il metabolismo endolinfatico.
Patogenesi della Vertigine Posizionale Parossistica Benigna
L’origine periferica e più precisamente dai recettori del canale semicircolare posteriore (CSP), e più raramente del laterale (CSL) è universalmente accettata. Le ipotesi patogenetiche intese a giustificare come il posizionamento declive dell’ampolla del canale semicircolare ne possa provocare la stimolazione, sono sostanzialmente due: la cupulolitiasi e la canalolitiasi.
Secondo la teoria della cupulolitiasi (Schuckencht) otoconi distaccatisi dalla macula dell’utricolo, posizionandosi sulla cupula del CSP, la rendessero sensibile al cambiamento di rapporto con la forza di gravità in seguito ad un movimento sul piano verticale, cioè su quello del CSP.
Tale movimento infatti provocherebbe una deflessione ampullifuga delle ciglia dei recettori canalari con conseguente imponente stimolazione del nervo ampollare e la comparsa del tipico nistagmo parossistico.
Una deflessione opposta si verificherebbe all’esecuzione del movimento opposto, con la stimolazione inibitoria dei recettori e la comparsa di un nistagmo parossistico simile, a direzione invertita.
Secondo la teoria della canalolitiasi, invece, particelle a densità elevata, di origine otoconiale o di altro tipo, come coaguli, globuli bianchi o altro, disperse nel lume del canale semicircolare (posteriore o laterale), sarebbero libere di muoversi sotto l’azione della forza di gravità andando a posizionarsi nella zona più declive del canale durante ogni movimento del capo.
Quadro clinico della Vertigine Posizionale Parossistica Benigna
Un paziente affetto da VPPB lamenta più o meno chiaramente vertigini oggettive di breve durata molto intense e legate a certi movimenti del capo spesso accompagnate da importante corredo neurovegetativo.
VPPB del CSP
Il paziente spesso racconta lo scatenarsi della vertigine al momento di eseguire movimenti specifici quali quello di coricarsi nel letto o di alzarsi dal letto, nell’alzare la testa, nel volgere rapidamente la testa.
Nella maggior parte dei casi la vertigine si manifesta con un preciso rapporto con il letto, è una vertigine che sveglia, notturna, o una vertigine del risveglio, tanto è vero che i pazienti con VPP anche se non benissimo comunque riferiscono di stare meglio in piedi.
A parte la nausea, il vomito, la sudorazione e altri sintomi da stimolazione vagale non sono mai associati alla vertigine sintomi neurologici o uditivi. Il paziente con VPP ha spesso un atteggiamento particolare con il collo irrigidito, mette molta cautela nell’eseguire i movimenti e racconta di dormire con due guanciali.
VPPB del CSL
Il paziente affetto da VPP del CSL lamenta ancora vertigini oggettive posizionali, ma che insorgono soprattutto nei movimenti laterali del capo, ruotando la testa da supino verso destra e verso sinistra.
Spesso il paziente riconosce che da un lato la vertigine è più intensa e dall’altro meno, ma non sono rari i casi in cui il soggetto, data la violenza della sintomatologia, la descrive come continua inducendo, in fase di anamnesi un possibile errore diagnostico differenziale con la grande vertigine periferica da perdita acuta monolaterale della funzione vestibolare.
Altre caratteristiche differenziali della VPP del CSL rispetto a quella del CSP sono la minore latenza di scatenamento della vertigine, la sua durata maggiore, la non affaticabilità. Il nistagmo caratteristico è ancora un nistagmo parossistico, ma in questo caso orizzontale, tipicamente geotropo, bidirezionale, cioè destro in fianco destro e sinistro in fianco sinistro; le manovre
scatenanti sono infatti la rotazione del capo o dell’intero corpo dalla posizione supina verso destra o verso sinistra.
Nella forma con NyPP geotropo il lato interessato dalla patologia è quello dove il nistagmo è più intenso; mantenendo la testa ruotata in questa posizione, all’esaurimento del NyPP geotropo si osserva spesso un’inversione del NY, che diventa apogeotropo, con caratteristiche di stazionarietà.
L’evoluzione della vertigine è variabile, infatti vi possono essere casi nei quali la vertigine si esaurisce in un singolo periodo con graduale diminuzione dei sintomi e guarigione completa oppure periodi di vertigine che si ripetono dopo intervalli di tempo più o meno lunghi (VPP recidivante), oppure vi sono rari casi nei quali si può parlare di uno stato vertiginoso permanente resistente alla terapia.
E’ importante sottolineare che anche una volta risolto l’episodio acuto l’instabilità posturale tipica che si accompagna alla vertigine e anche talora il corredo vagale possono permanere più a lungo della vertigine stessa.
Diagnosi della Vertigine Posizionale Parossistica Benigna
Oltre che sull’anamnesi la diagnosi definitiva di VPP si basa sul rilevamento, nell’eseguire la manovra di Dix-Hallpike, del tipico nistagmo parossistico (NyPP).
La Manovra di Hallpike consiste nel far passare il paziente dalla posizione seduta e con testa ruotata di 45° verso il lato in esame, a quella con testa iperestesa fuori dal letto; questa posizione viene mantenuta fino a 2 minuti e poi, rapidamente, il paziente viene portato nuovamente seduto. La manovra di Dix-Hallpike può essere eseguita a occhio nudo o con
occhiali di Frenzel o sotto video-oculoscopia.
La manovra di Dix-Hallpike risulta positiva quando il paziente riferisce la comparsa della vertigine e l’esaminatore osserva il NyPP paradigmatico della VPP da CSP.
Il nistagmo parossistico paradigmatico (NyPP) Le caratteristiche del NyPP nella VPPB del CSP sono le seguenti:
– Insorge con latenza: cioè tra il raggiungimento della prima posizione di Dix-Hallpike e la comparsa del NyPP possono intercorrere anche diversi secondi (circa 15’’)
– Ha andamento parossistico, cioè la sua velocità angolare cresce progressivamente e in maniera rapida, raggiunge un plateau e successivamente decresce in maniera analoga fino a scomparire.
– Ha una durata limitata che in genere non supera il minuto
– È un nistagmo dissociato, cioè prevalentemente rotatorio nell’occhio ipsilaterale, e prevalentemente verticale nell’occhio controlaterale
– È un nistagmo geotropo cioè batte verso la terra, nella prima posizione di Dix- Hallpike.
– Inverte la sua direzione quando si riporta il paziente in posizione seduta
– È affaticabile, cioè la ripetizione delle manovre scatenanti provoca la graduale riduzione della sintomatologia e dell’intensità del nistagmo.
Ny nella VPPB del CSL
Il nistagmo caratteristico nel paziente affetto da interessamento del CSL è ancora un nistagmo parossistico, ma in questo caso orizzontale, tipicamente geotropo, bidirezionale, cioè destro in fianco destro e sinistro in fianco sinistro; le manovre scatenanti sono infatti la rotazione del capo o dell’intero corpo dalla posizione supina verso destra o verso sinistra.
Nella forma con NyPP geotropo il lato interessato dalla patologia è quello dove il nistagmo è più intenso; mantenendo la testa ruotata in questa posizione, all’esaurimento del NyPP geotropo si osserva spesso un’inversione del NY, che diventa apogeotropo, con caratteristiche di stazionarietà.
Terapia della Vertigine Posizionale Parossistica Benigna
Nel corso degli anni molti autori hanno proposto proprie manovre di riposizionamento, alcune anche molto efficaci, ma il concetto basilare rimane sempre quello di provocare una fuoriuscita delle particelle dal canale senza utilizzare alcuna accelerazione particolare. Si descriveranno solo le due manovre più conosciute ed utilizzate.
La manovra liberatoria di Semont
Con la manovra di Semont si porta il paziente dalla posizione seduta con le gambe fuori dal letto, verso il lato colpito dalla VPP avendo cura di orientare la testa in modo da provocare la comparsa del nistagmo; nella forma semplificata di tale manovra la testa è girata di 45° verso il lato sano; il paziente viene tenuto in questa posizione fino all’esaurimento della vertigine e altri 2-3 minuti; si esegue quindi un movimento del tronco del paziente fino a portarlo nella posizione diametralmente opposta avendo cura di mantenere
lo stesso orientamento della testa; in questa posizione compare il nistagmo che ha la stessa direzione del precedente, detto liberatorio, in quanto testimonia l’avvenuto movimento in direzione ancora ampullifuga dell’ammasso di otoliti.
Si mantiene questa posizione per alcuni minuti e poi lentamente si riconduce il paziente in posizione centrale.
La manovra di Epley
Nel 1992 Epley introduce un altro tipo di manovra liberatoria, basata sul concetto di canalolitiasi, detta “canalith repositioning manoeuvre”. Tale manovra viene eseguita portando rapidamente il paziente nella posizione di Dix- Hallpike scatenante e da qui facendo ruotare lentamente ma in modo continuo la testa del paziente vero il lato sano fino a portarla nella posizione di Dix-Hallpike.
Hallpike opposta; con tale movimento si cerca di indurre la graduale migrazione dei detriti otoconiali dal braccio ampollare del CSP verso la crus commune ed infine nel vestibolo. Anche con questa manovra la fuoriuscita delle particelle dal canale sarà indicata dalla comparsa del nistagmo liberatorio, cioè di un nistagmo con la stessa direzione di quello evocato con il primo posizionamento.
Dai dati della letteratura emerge come i due tipi di manovra liberatoria siano tutte ugualmente efficaci con risoluzione della sintomatologia posizionale in una o due sedute; la scelta dell’una o dell’altra tecnica dipende soprattutto dalla preferenza del terapista e dalle condizioni di mobilità del paziente.
Anche per la VPP da CSL la terapia fisica risulta essere quella di maggiore successo, anche se per questa forma la tendenza alla risoluzione rapida e spontanea è ancora maggiore rispetto alla forma da litiasi del CSP.
Le tecniche ad oggi disponibili sono la Posizione Liberatoria Coatta (PLC) di Vannucchi, le manovre di “barbecue” di Lempert e Baloh e la manovra liberatoria di Gufoni.
La PLC consiste nel far giacere il paziente affetto da VPP del CSL in forma geotropa, almeno 12 ore ruotato sul lato non interessato dalla litiasi canalare: durante questo periodo il CSL litiasico si viene a trovare in posizione verticale, favorevole alla graduale fuoriuscita dei canaliti dal canale stesso, sotto la spinta della forza di gravità.
Tale tecnica sfrutta quindi un meccanismo di decantazione.
Le manovre di “barbecue” invece prevedono la rotazione del paziente dalla posizione supina verso il lato sano di 270° (Lempert) o 360° (Baloh) al fine di guidare con gradualità le particelle al di fuori del canale.
La dott.ssa Sabrina Corno, Otorinolaringoiatra, si occupa di Vertigini a Milano, Patologia dell’Orecchio, del Naso e della Gola a Milano, Monza e Brianza presso lo Studio Medico Otorino
Milano in Piazza Corte Grande 27, Gessate.